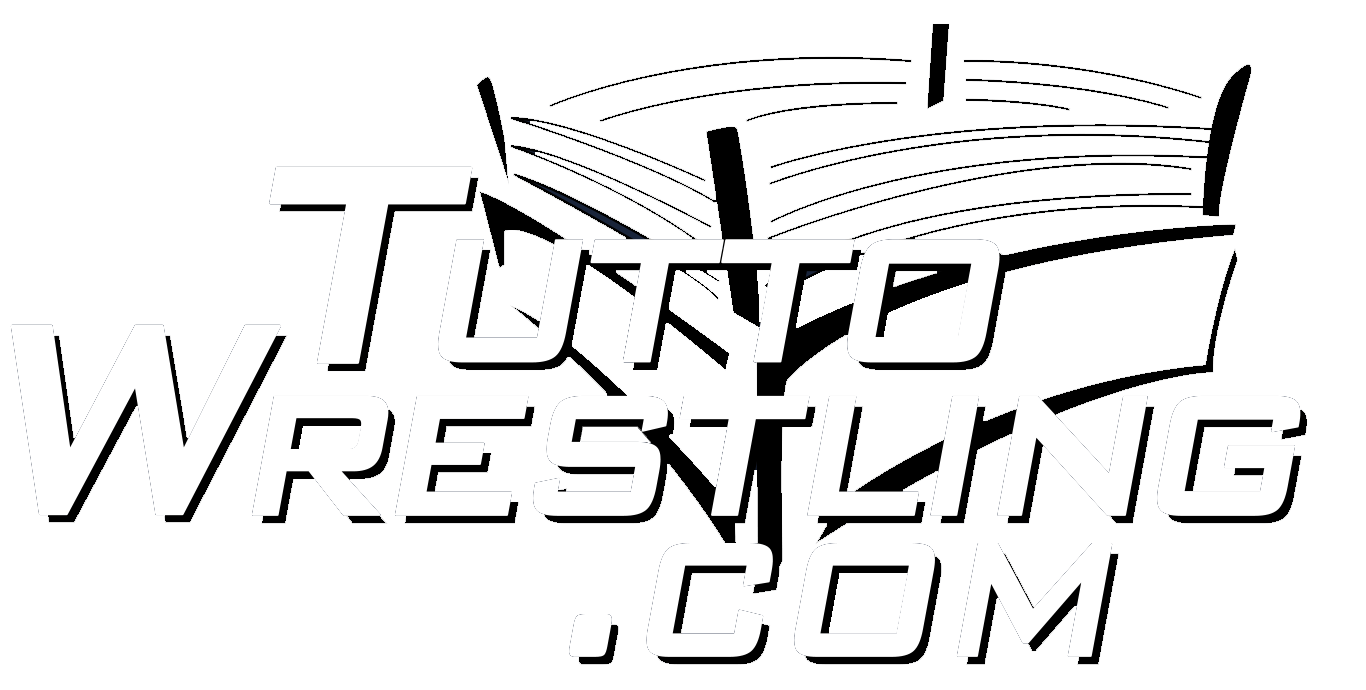Gorilla Position #18 – Il peso di un titolo

Quando iniziai le scuole elementari ero un bimbetto magrolino, con i capelli lisci e a caschetto, sempre silenzioso e ben vestito. Odioso. Ricordo che, in una delle verifiche nel corso della mia proficua carriera nella scuola primaria, affrontai con baldanza e coraggio ogni domanda. Convinto di saperne una più del diavolo. E invece crollai miseramente, come un moonsault di Red Velvet, su uno e un solo quesito. No, non era il teorema di Ruffini. Nemmeno il principio di Archimede, le leggi di Keplero o chissà che altro arzigogolo. Bensì, pesa di più 1 kg di piombo o 1 kg di piume?
Ma ovvio, pesa di più il piombo. Giusto? Già. Poco importa che esista il peso specifico. 1 kg rimane 1 kg, così come un titolo è sempre un titolo. Ma, marzullianamente scostandomi il ciuffo ribelle dalle palpebre, mi interrogo: per un performer al giorno d’oggi un titolo è di peso o pesante? Ovverosia, narrativamente è un onere scrivere la storia titolata di un wrestler? O è, ancora e nonostante tutto, l’unica cosa che conta? E nondimeno, quando lo conquisti, cosa succede?
Perché se guardiamo soprattutto in casa WWE, sembra davvero che le cinture siano niente di più, niente di meno che un accessorio. Non l’obiettivo ultimo cui tendere, ma un artificio creativo, un orpello che viene assegnato o tolto a piacimento, per raccontare un intreccio che a volte non si regge da solo e altre nemmeno ne avrebbe bisogno. O, peggio ancora, un’entità senza definizione, che viene dimenticata alla vita di gente che nemmeno lotta, semplicemente perché non c’è niente che di questo si possa narrare.
Quando si crea una narrazione, scomponendone i fattori ai minimi termini, solitamente abbiamo due (o più) personaggi, un obiettivo, una motivazione scatenante e il mezzo per ottenerlo. Che tradotto nel gergo wrestling è qualcosa tipo: sono un face (personaggio), sono stufo di fare la figura del fesso (motivazione), voglio affrontarti in un match (mezzo), per strapparti il titolo a WrestleMania (obiettivo).
Royal Rumble, un evento assolutamente deludente sotto tanti punti di vista. Ma la cosa che più di ogni altra mi ha lasciato perplesso è stata proprio la gestione dei due titoli. Usati come carne da macello solo per trovare nuove motivazioni (e non obiettivi) per questo fantomatico Reigns vs Lesnar di Wrestlemania. La vittoria titolata di Lashley non ha avuto alcuna importanza, perché il valore della cintura è finito letteralmente sotto le suole delle scarpe. Il nuovo campione non era che comparsa. Togli Lashley e metti chiunque altro e sarebbe andata esattamente allo stesso modo.
Elimination Chamber, stesso copione. Il titolo diventa mezzo di dispetto, mi hai fatto uno sgarbo? Bene, entro nella Chamber, mi vendico della malefatta salvo poi scagliare via la suddetta cintura al grido di “chissenefrega del titolo”. L’infortunio di Lashley è una parziale scusante, proprio alla luce di quanto detto sopra. La narrazione ha invertito i fattori, ha reso campioni e titoli schiavi di un contesto esterno, per arricchire un’epica già sufficientemente opulente.
Anche in AEW sembra che la scrittura del titolo sia ben più problematica dell’approccio allo stesso. Britt Baker e Adam Page che vivono un anno (o più) di inseguimento, fatto di grande hype, un momentum lavorato con lo scalpello. Poi la vittoria e da qui la discesa lenta e inesorabile verso il disinteresse per la prima, verso tanti punti di domanda per il secondo. Avversari episodici, nessuna costruzione particolare, nessuna trama in cui ricostruire la dicotomia tra chi vuole conquistare e chi non vuole essere conquistato.
Il titolo TNT, nato sotto la stella bipolare di Cody Rhodes, continua in questo suo ondivago percorso dal nutrito albo d’oro. Senza che vi sia una preparazione al cambio, ma solo una serie di mattoncini messi a posteriori. I Jurassic Express hanno sofferto della sindrome Lashley, ovverosia trovarsi a conquistarsi un ruolo in una storia d’altri. Loro che il ruolo, in quanto campioni, dovevano, dovrebbero averlo di default. E invece tutti a guardare Revolution aspettando il momento del dissidio tra gli sfidanti. E bene, benissimo, hanno fatto Jungle Boy e Luchasaurus, confermandosi con assoluta dignità e merito in un match davvero rischioso per la loro già traballante run.
Legittimare un campione crea i presupposti per valorizzare gli sfidanti. Il viceversa, per quanto altrettanto valido, è un po’ un contorsionismo narrativo. Rocky Balboa era un underdog, venuto dal nulla, la sua epica personale diventa storia perché la figura del campione, Apollo Creed, è soverchiante. Nella conquista, nella legittimazione e nella ricerca di nuovi obiettivi e traguardi si gioca la statura di un campione. Che altrimenti vive solo nell’attesa, tendenzialmente poco interessante, di essere detronizzato.
In tal senso, Roman Reigns è diventato, inerzialmente, il prototipo di un disegno narrativo semplice, per quanto incoerente. Capotavola, capotribù, capopopolo, capoluogo di provincia. Jukebox di catchphrase altisonanti che poi si traducono in una striscia, impressionante, di vittorie “con l’aiutino”. E ci si può lamentare di tutto questo, per questa discontinuità tra il parlato e la statistica, ma giorni alla mano, tempo on screen, curriculum immacolato in termini di vittorie. Insomma, mettiamo una spunta alla legittimazione, se mai ci fossero dubbi in rapporto al cugino di The Rock.
Possiamo quindi chiederci, a pieno titolo e con assoluto interesse: chi batterà Roman Reigns? Sarà un momento epico? Sì. Sarà Brock Lesnar? Chi lo sa, il pubblico si divide, anche nei nostri canali social. Ma in ogni caso in una WrestleMania che definire in chiaroscuro è quasi essere blasfemicamente riduttivi, quanto hype c’è per questo match? Enorme. Altissimo. Infinito. Segno che alla fine, la semplicità, pur disordinata, basta e avanza.